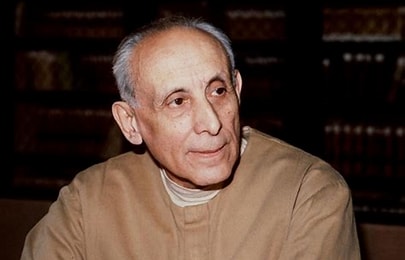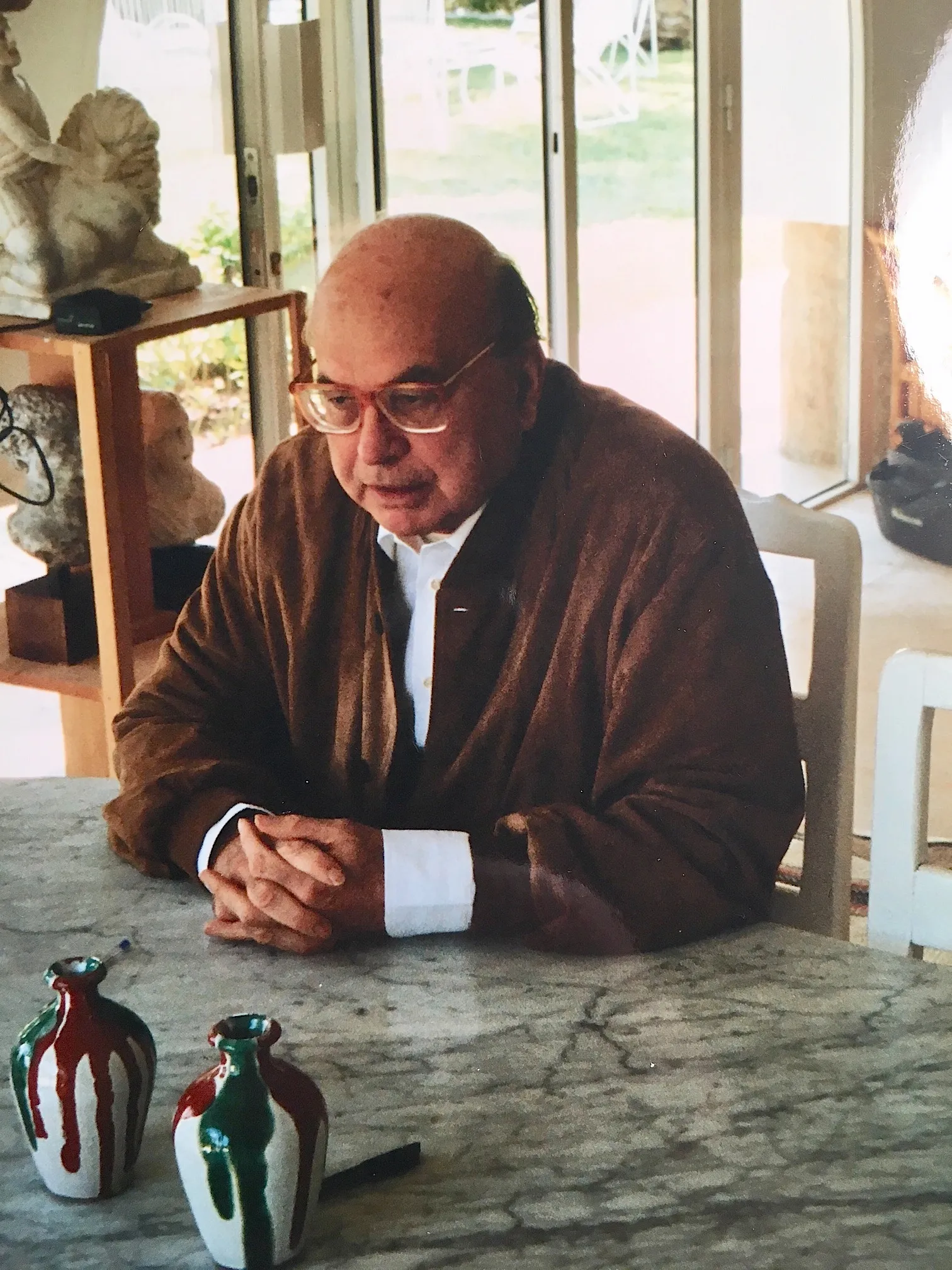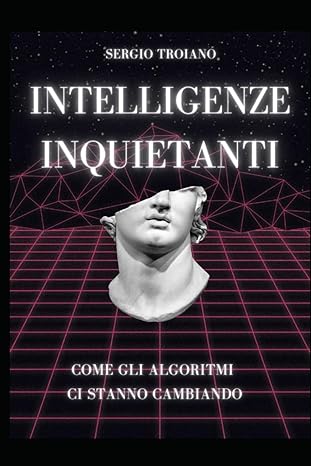Si incontrarono (e fu l’unica volta) in Versilia ad inizio secolo, nella villa del poeta abruzzese. Umberto Saba aveva vent’anni, Gabriele d’Annunzio quaranta. Mezzano dell’incontro fu Gabriellino, figlio primogenito di d’Annunzio che allora abitava, come Saba, a Firenze.
Il Vate, ancor giovane allora, aveva un sorriso affascinante. Parlava poco e lasciava, senza sforzo, questa cura agli altri. Ascoltava musica di Wagner suonata alla pianola e lavorava ad un saggio commemorativo del Giacosa: non perché ne fosse convinto davvero, ma per la sua amicizia con lo scrittore da poco defunto, per far cosa grata alla vedova e per i soliti motivi venali.
A Saba l’autore delle “Laudi” parlò male del Carducci, un po’meno male di Pascoli. Ascoltò volentieri qualche poesia di Saba ed ammirò, o finse di ammirare (“ammirare – osserva lo scrittore triestino – era un poco il suo mestiere”) la dolcezza di quei versi. I figli di Gabriele – ricorda ancora Saba – avevano la proibizione di chiamarlo in pubblico “papà”: dovevano chiamarlo “maestro”.
Durante quella strana visita al Bianco immacolato signore - la memorabile settimana dannunziana della sua giovanezza – il poeta triestino sacrificò su consiglio di Gabriellino il suo biondo pizzetto, che lo rendeva somigliante al Vate, per far contento il già famoso ospite. “Solo nella perfetta calvizie – gli disse poi d’Annunzio – si rivela la perfetta nobiltà di una testa”, sempre che questa (beninteso) sia ben modellata.
Ma quel che più splende nella memoria di Umberto Saba, ormai anziano, è un piatto di pasta al pomodoro che venne, nell’occasione, servita da Rocco Pesce. Si trattava di una minestra sontuosamente condita che al giovane triestino apparve come una purpurea meraviglia. “Quel piatto – vividamente ricorda – sembrava una bandiera trionfale”. Era semplicemente preparato all’uso meridionale ma Umberto, rapito, pensò addirittura che fosse una nuova invenzione (l’ennesima) dell’Imaginifico.
Ruggero Morghen