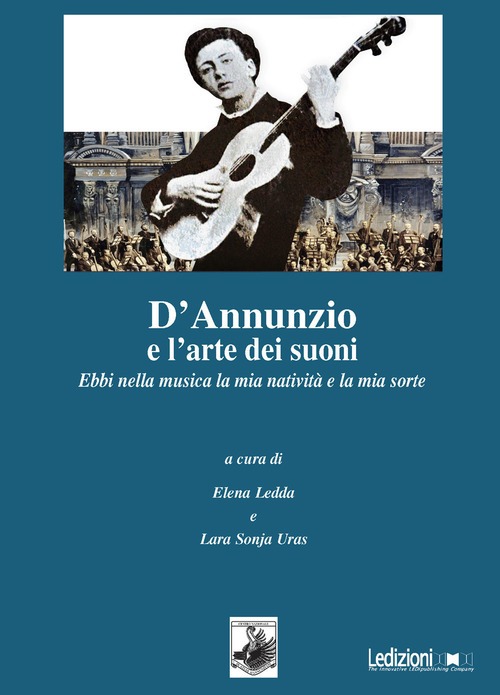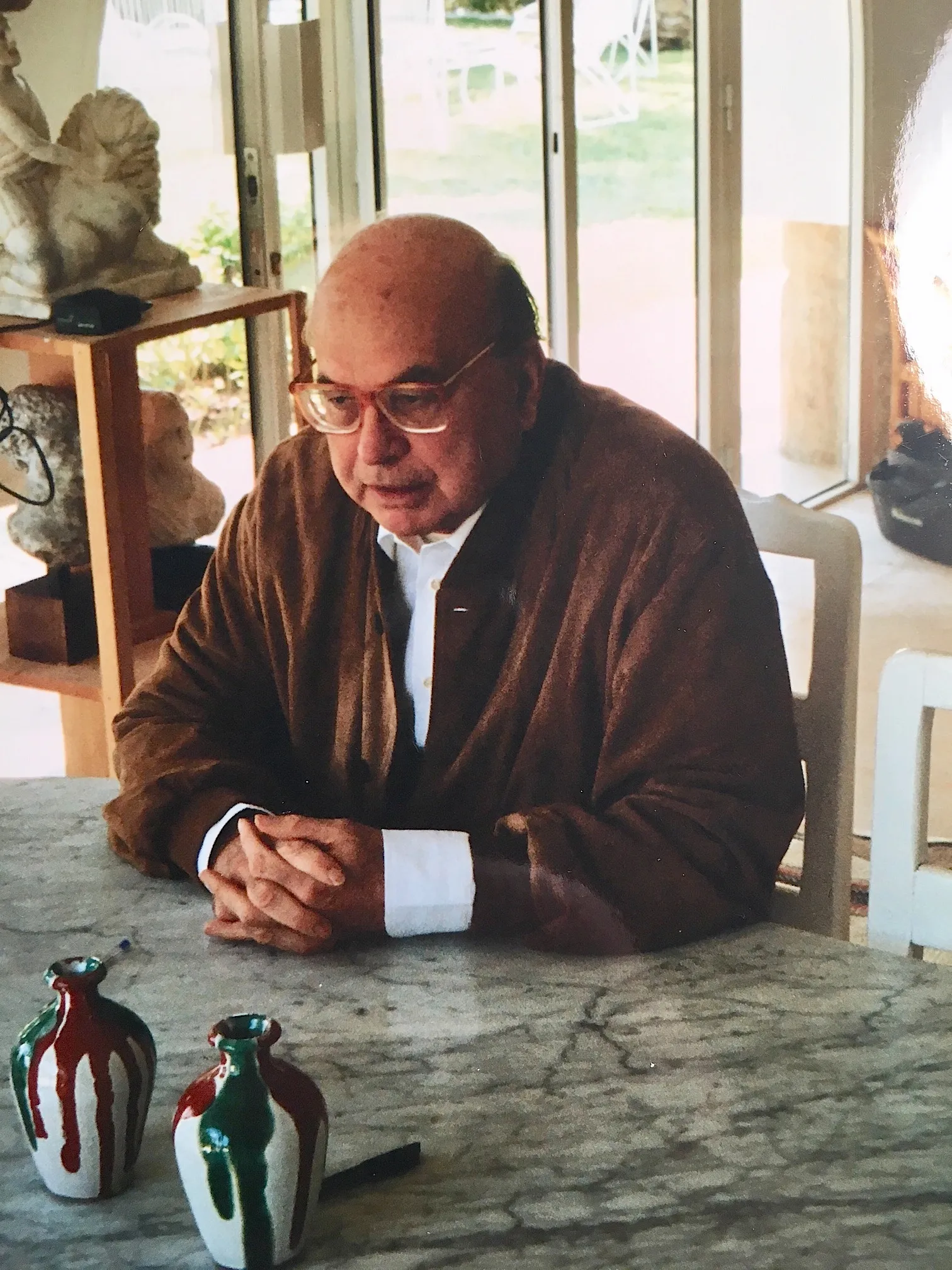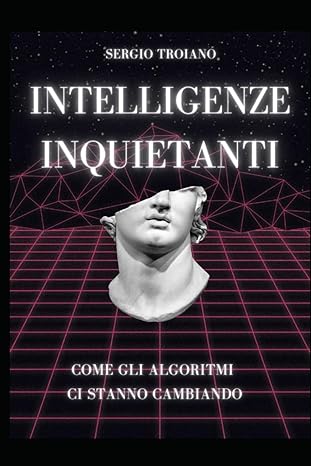Il 27 maggio 1923, esattamente cento anni fa, nasceva a Firenze don Lorenzo Milani. L’anniversario riaccende intorno alla figura inimitabile del sacerdote italiano le attenzioni contrastanti di sempre. Tornano a circolare le divise consunte con cui si è sempre voluto imbrigliare l’anima del Priore di Barbiana, grande “irregolare” del cattolicesimo italiano della seconda metà del Novecento: le maschere dell’utopista pacifista, il tribuno dei poveri, o – come lo disegnano i suoi detrattori – del piccolo despota giacobino, guastatore della scuola italiana, ispiratore di un classismo intollerante.
In realtà, l’unico abito che si attaglia a don Milani è quello che ha sempre portato. L’abito del sacerdote. «Don Lorenzo» ha detto uno dei suoi ragazzi «non è che si mettesse la tuta d’operaio per stare vicino al popolo. Non ha mai messo tute da operaio. Ha sempre fatto il prete, e basta».
Già Neera Fallaci, che fu la sua prima appassionata biografa, registrava: «È assai probabile che la conversione [di Milani] si sia stabilita sui sacramenti della confessione e dell’eucaristia: punto focale dello stesso suo sacerdozio».
Quando si converte e chiede di farsi prete, Alla madre Alice, ebrea agnostica, che manifesta tutti i suoi dubbi amari per la strada imboccata dal figlio, Lorenzo stesso cerca di spiegare che essa non poggia su una sicurezza empia e presuntuosa, ma sulla grazia donata dai sacramenti. Scrive: «Te vuoi dire che è troppo presto per me per sapere se seguiterò tutta la vita a volere così. Io ti rispondo che è di fede (Concilio Tridentino) che nessuno può essere sicuro della propria perseveranza (eccetto naturalmente la signora Cesarina e tutte coloro che fanno la comunione per nove primi venerdì del mese).
Ma ciò che non possiamo sperare dalle nostre forze lo possiamo sperare dal Signore che in fondo vuole così». La percezione di non poter vivere senza i sacramenti diventerà in lui sempre più acuta. In una sua celebre invettiva contro gli intellettuali laici borghesi, rimasta registrata su un nastro ai tempi di Barbiana, dice davanti ai suoi ragazzi: «Per me che l’ho accettata, questa Chiesa è quella che possiede i sacramenti.
L’assoluzione dei peccati non me la dà mica l’Espresso. L’assoluzione dei peccati me la dà un prete. Se uno vuole il perdono dai peccati si rivolge al più stupido, arretrato dei preti pur di averla. […] In questa religione c’è fra le tante cose, importantissimo, fondamentale, il sacramento della confessione dei peccati. Per il quale, quasi per quello solo, sono cattolico. Per avere continuamente il perdono dei miei peccati».
Negli ambienti proletari e rurali in cui gli capita di vivere il suo sacerdozio, Milani registra l’avvizzire della memoria cristiana e il dissiparsi del cristianesimo in abitudine borghese anche nei cuori degli operai e dei contadini. Le messe e le processioni sono ancora piene di gente, ma secondo lui anche per quelli che distrattamente affollano le chiese per le feste patronali «la religione è roba da ragazzi», «il peccato originale sull’anima fa meno male di un’infreddatura», e «lo stare in grazia di Dio non è un problema quotidiano.
O meglio, non è il problema quotidiano fondamentale». Dentro le tante intemperanze di don Lorenzo, anche dietro le sue polemiche corrosive e i suoi rigorismi a volte impietosi, si avverte spesso un grido di fede davanti alla mutazione genetica che in quei decenni va cancellando anche nel clero la percezione della natura sacramentale della Chiesa, e la sostituisce con i fasti dell’organizzazione e della mobilitazione auto-promozionale.
Don Milani stronca in maniera fin troppo sommaria i preti tutti presi a organizzare attività ludiche e ricreative per “attirare i giovani”, in angosciosa gara coi circoli comunisti. In quegli anni, cominciano le «prove esibizionistiche dell’attivismo ecclesiastico». Iniziano a spuntare anche i preti chitarristi, cantanti, tuffatori e quelli che organizzano sfilate di indossatrici per “cristianizzare” l’ambiente della moda.
Un accaparramento clericale di ruoli e di funzioni dove si perde di vista l’unica missione che compete al prete in quanto tale: la cura d’anime attraverso i sacramenti. «Non si può esigere la supervisione su tutti gli aspetti della vita del nostro popolo», scrive Milani.
Secondo lui, l’idea che il prete possa monopolizzare tutte le funzioni e i ruoli legati alla vita comunitaria «non è fede nel sacerdozio, ma superbia volgare. Del sacerdote la fede ci dice solo che è latore dei sacramenti; solo per quelli è insostituibile».
La sua famosa esperienza di scuola popolare, tirata su prima per i figli degli operai e dei disoccupati analfabeti di Calenzano, e poi per quelli dei rozzi montanari e dei contadini di Barbiana, continua a essere al centro di controversie.
Don Milani educatore può essere accusato di classismo esasperato, di autoritarismo e rigorismo invasivo («noi si fa scuola dieci ore al giorno, sette giorni su sette»). Eppure, anche la foga unilaterale con cui si immerge nella sua opera ha come orizzonte ultimo la salvezza eterna delle anime dei ragazzi. Lui toglie il crocefisso dalle stanze della scuola, popolare, per far vedere anche ai genitori atei e comunisti dei suoi allievi che quella non è “la scuola del prete”.
Ma poi scrive: «Da bestie si può diventar uomini e da uomini si può diventar santi. Ma da bestie santi d’un passo solo non si può diventare».

Il suo libro Esperienze pastorali, su cui si abbatteranno le stroncature di Civiltà Cattolica e la disposizione di ritiro dal commercio comminata dal Sant’Uffizio, non è altro che un’apologia – a tratti segnata da un dogmatismo indigesto – della scuola popolare come strumento per ridestare nei «paria italiani» quel minimum di sensibilità umana senza cui ogni annuncio di salvezza rischia di passare come acqua sui sassi. Così, proprio la scuola diventa anche «segreta fucina» di confessioni e comunioni.
L’inquietudine missionaria di don Milani si esprime in maniera paradossale anche nei messaggi imaginari posti da lui all’inizio e alla fine del suo libro “Esperienze pastorali”, pubblicato nel 1954: una dedica e poi una “lettera postuma dall’oltretomba” ambedue rivolti agli immaginari “missionari cinesi del Vicariato apostolico d’Etruria”, che verranno a riportare il Vangelo nel cuore di un’Italia immaginata come terra desolata, dove duemila anni dopo la nascita di Gesù sembra sparita ogni vibrazione di vita cristiana, e del cristianesimo rimangono solo i ruderi del passato.
Una immagine che profetizza come il disastro della scristianizzazione moderna abbia preso forma nella separazione della Chiesa dal popolo, e implicitamente suggerisce da quale sorgente di misericordia può ripartire sempre, anche tra le macerie, il miracolo della vita cristiana.
«Questo lavoro» scrive don Milani nel suo incipit paradossale di “Esperienze pastorali” «è dedicato ai missionari cinesi del Vicariato apostolico d’Etruria, perché contemplando i ruderi del nostro campanile e domandandosi il perché della pesante mano di Dio su di noi, abbiano dalla nostra stessa confessione esauriente risposta.
Lui solo vogliano ringraziare della nostra giusta condanna che ad essi ha dato occasione di eterna salvezza. Se dunque da questa umile opera potranno per il loro ministero trovare ammaestramento, non manchino di pregare in cinese il Cristo misericordioso perché dei nostri errori, di cui siamo stati un tempo vittime ed autori, voglia misericordiosamente abbreviarci la pena». Alla dedica, don Lorenzo faceva seguire un passaggio eloquente della Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani: «I rami sono stati recisi affinché tu fossi innestato. Per la loro incredulità son stati recisi. Tu dunque stai saldo nella fede».
Gianni Valente