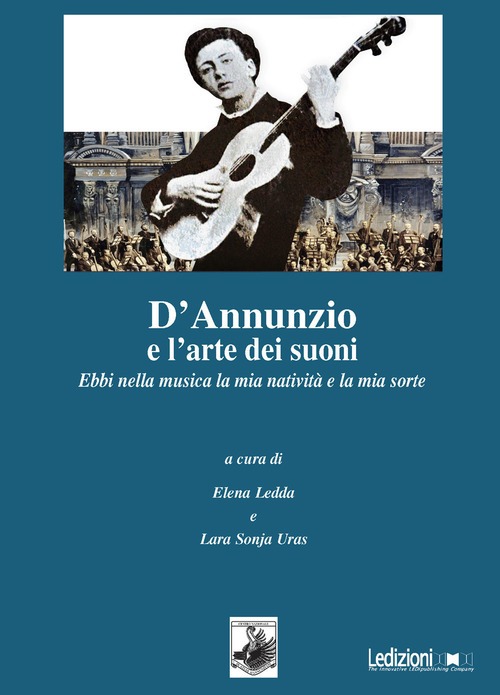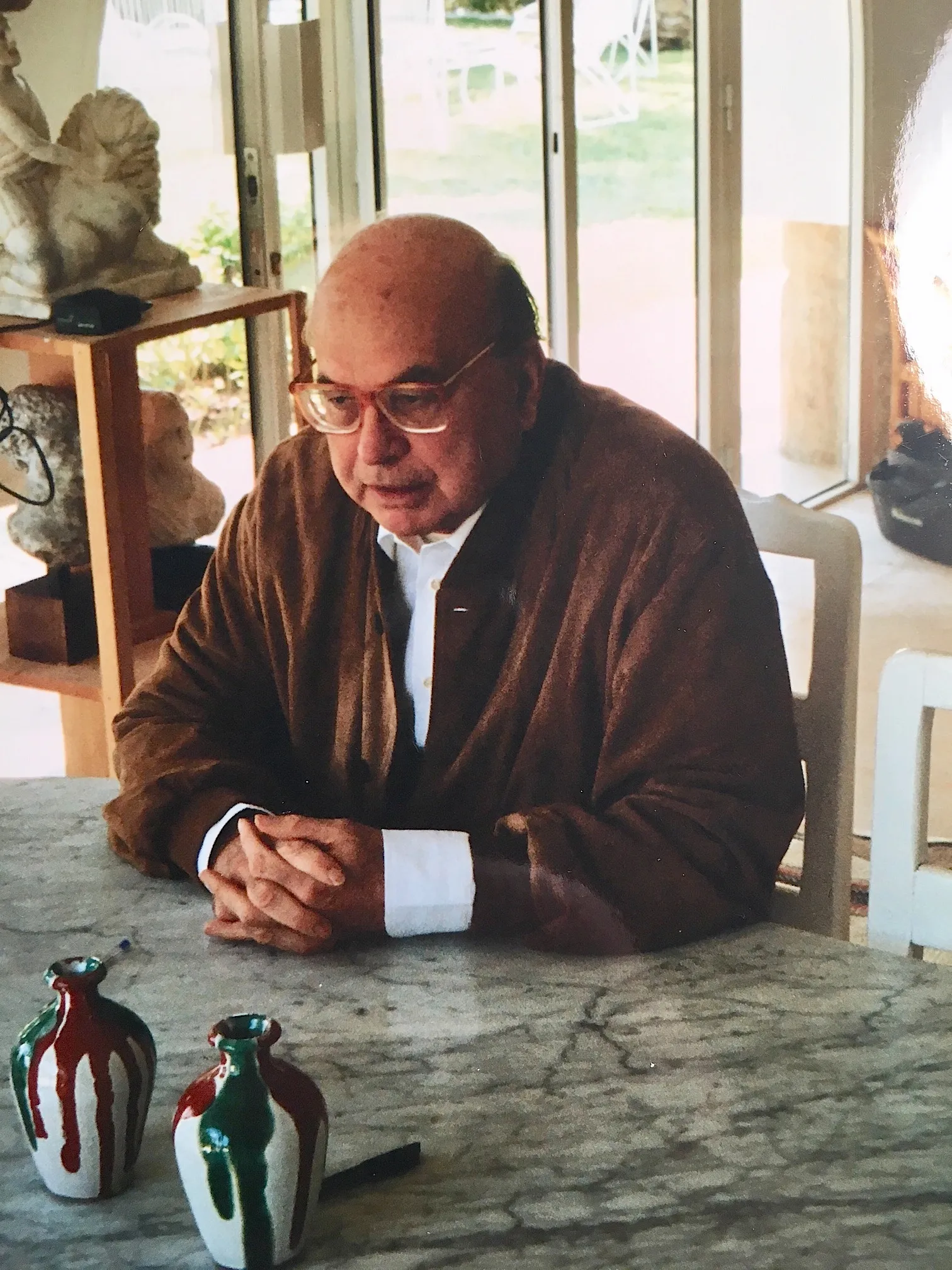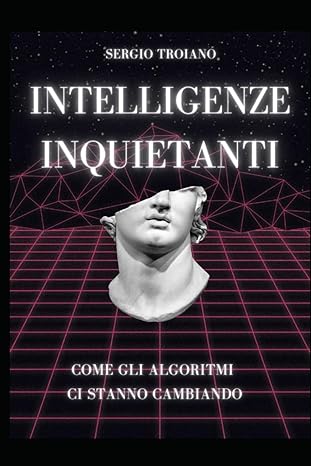1. C’è la libertà, al cuore della democrazia. Ce ne ricordiamo a fatica per uno strano sortilegio. Un po’ sembra scontato ma un po’ sorprende, visto che la questione in sé contempla la difficoltà di una sfida, specie nelle fasi di cambiamento. La libertà non è un fatto bensì una conquista, ovvero una sollecitazione intellettuale e morale interna al dinamismo che anima la coscienza dell’uomo, determinandone l’azione nel mondo. La si può dividere in due parti, una positiva e l’altra negativa: infatti, un conto è la “libertà liberante”, principio e motore di liberazione personale e collettiva, altro è la “libertà egocentrica”, per la quale l’individuo si specchia in un’immagine di autosufficienza e rivendica il suo imperio, trascurando limiti e responsabilità. Pur con sfumature di vario tipo, questa polarizzazione tiene Ne deriva allora una considerazione che intercetta e interpella, ogni volta in modo nuovo, il dover essere dei cristiani: e cioè che la vera libertà s’accompagna sempre alla giustizia e alla solidarietà, costituendo il fattore che impedisce alla prima di perdersi nel giacobinismo dei diritti e alla seconda di degenerare nel corporativismo delle aspettative.
Nella storia del pensiero l’idea greca di uomo, animale sociale e razionale, è stata successivamente ampliata e superata. Tommaso ha messo in chiaro come la definizione di “animale politico” (non semplicemente sociale) fosse più adeguata a rappresentare l’uomo strettamente legato alla sua comunità. Pertanto, quello che chiamiamo animale politico è anche, secondo la formula dell’Aquinate, “eminentemente comunicativo” perché naturalmente capace di relazionarsi con altri e di mettere in comune i beni della vita. È un dato iscritto nella condizione umana alla quale, infine, pertiene la necessità di un principio direttivo a sostegno e tutela della civile convivenza. Questa regola comporta l’identificazione dell’autorità, sebbene di un’autorità che non può prescindere dalla “libertà naturale” dell’uomo, non avendo egli, dopo la Caduta, perso tutto ma solo i doni preternaturali e tra questi evidentemente la vicinanza all’Amore assoluto, fonte di piena libertà. Ecco la differenza dalla concezione che stabilisce la necessità del salto da una condizione all’altra: non esiste un prima e un dopo, alla Rousseau, perché in origine l’uomo dello stato di natura in sé è già sociale o più precisamente politico.
Un riverbero intenso di questa visione antropologica, foriera di disposizioni adatte a conformare i rapporti tra uomo e Stato secondo regole di libertà pluralismo e tolleranza, si avrà nell’opera matura del neo tomista Maritain.
2. Oggi siamo lontani da una tale forma mentis. La rottura con la filosofia cristiana - unità lessicale perlomeno problematica - viene da lontano, risale all’illuminismo e ai furori della Rivoluzione francese, si consolida nel materialismo filosofico tedesco, esplode nella fredda ironia di Feurbach per il quale una tale filosofia s’appalesa incongruente al pari di una botanica o una medicina cristiana. Al grido di Zarathustra, “Dio è morto”, l’Occidente si dispone a un salto di valori. Con Marx e i suoi eredi la rivoluzione ha poi assunto, per tutto il Novecento, il carattere di totale affrancamento dal “bisogno della religione”, essendo al più un bisogno da accogliere e ricomprendere su un altro terreno filosofico e politico, quello della praxis finalizzata a portare a compimento, nella sfera dell’immanenza, una società nuova e un uomo nuovo. Ora, se l’impalcatura del marxismo ha ceduto a causa della fallita esperienza del socialismo reale, non ha ceduto però quell’orizzontalismo antropologico che esclude la domanda religiosa e radicalizza lo spirito d’indifferenza rispetto a ogni fede (salvo il ricorso a surrogati). Tuttavia, di fronte all’odierno liberismo etico, adombrante una felicità che sembra non esigere fatica, sta il contrappello di una rinnovata etica della libertà. In sostanza, la lezione del passato dà forma e tono a una riflessione sul futuro sempre nell’ottica di un confronto che, partendo da una motivazione di fede, consenta di parlare non contro la modernità, presa tutta in blocco e rifiutata alla radice, ma piuttosto su quale modernità sia possibile convergere in virtù di una feconda ispirazione ideale.
3. Una ricognizione stimolante, capace di leggere il movimento della storia, può essere favorita dall’esame dei grandi discorsi politici che hanno rappresentato uno spartiacque nella vita pubblica dei cattolici. Essi, uscendo allo scoperto proprio in nome della libertà, hanno lavorato nel secolo scorso alla edificazione di un progetto volto a realizzare una presenza organica nella società, arrivando ad assumere e conservare per quasi mezzo secolo la guida del Paese. È accaduto all’inizio del Novecento con Romolo Murri, l’apostolo della prima democrazia cristiana; quindi, all’indomani della Grande Guerra, è accaduto con Luigi Sturzo, il fondatore del Partito popolare; ed infine, nell’ora della Ricostruzione dell’Italia dopo la Seconda guerra mondiale, è accaduto con De Gasperi e i suoi amici di partito. In questo caso, fa testo emblematicamente il discorso tenuto da Guido Gonella al primo congresso della Dc, svoltosi nell’Aula Magna dell’università di Roma nella primavera del 1946 (24-28 aprile). Sono tre tappe fondamentali nella evoluzione del messaggio dei democratici cristiani. Non si comprende appieno la loro vicenda, a lungo egemone nel complesso del cattolicesimo italiano, se non all’interno di una operazione che ha visto l’apertura alla modernità come accettazione e rilancio del capitolo della libertà, secondo un’autonoma visione della politica. È stato un cammino sofferto, fatto di cadute e di riscatti, che restituisce a chi osserva dalle pendici dell’attualità il senso di marcia del cattolicesimo democratico e popolare.
4. All’inizio, quando il secolo Ventesimo muove i primi passi, sorge rapido con Murri il sogno di una nuova avventura. Come definire altrimenti la sua incontenibile e controversa iniziativa? Il giovane sacerdote marchigiano aveva il carisma dell’innovatore, ma forzando i tempi dell’innovazione - voleva il “partito cattolico” subito - cadde sotto i colpi della censura ecclesiastica. Fu Pio XII, nel 1943, a revocargli la scomunica: un anno dopo avrebbe lasciato questo mondo. L’intransigentismo dell’Opera dei Congressi era appassito, Murri ne voleva ripristinare il vigore e la ragione (anti liberale) spostando comunque l’asse della battaglia sul terreno della politica. La sua democrazia cristiana doveva presentarsi sotto il vessillo della giustizia e della libertà, andando ben oltre i confini dell’assistenza e della solidarietà, come pure aveva raccomandato Leone XIII con l’enciclica Graves de Communi Re (1901). Fu l’incendio che provocò l’intervento di una Gerarchia sempre più allarmata. Messo alle strette, Murri scelse di alzare i toni della disputa attorno un “cristianesimo più cristiano”, più vicino alle istanze popolari e più aperto alle novità del tempo, attribuendogli perciò la funzione di nerbo della vita democratica moderna. Il discorso che riassume questa opzione, Murri lo tenne il 31 agosto del 1902 a San Marino davanti ai militanti di un partito ancora in nuce, arrestato dal veto Il testo fu poi pubblicato, e oggi noi lo consociamo, con il titolo di “Cristianesimo e libertà”. Murri parla apertamente della “l’influenza sempre minore del pensiero e della vita cristiana sulla attività umana” e perciò, con il respiro del profeta, invoca a modo suo il ritorno al Vangelo. E la sua domanda, proprio in esordio, suona come una implicita esortazione: “La libertà può ella essere, per noi giovani cattolici italiani di oggi, un programma?”. Certo, dice Murri, e lo è perché mira alla liberazione del cristianesimo dai suoi connotati di religione dell’Ancien regime, in senso lato; una religione che in Italia, dopo Porta Pia, aveva disconosciuto tutto del Risorgimento, anche l ’ iniziale suggestione del neoguelfismo; ecco, pertanto, il significato del programma della libertà perché solo con esso il cristianesimo può rappresentare una “ondata fresca e sana” nel contesto di una società avvitata nella dialettica tra liberalismo e socialismo. “Siamo pronti”, afferma con quel tanto di spavalderia che i troppi avversari gli contesteranno; pronti a spingersi con il fervore degli ideali democratici e cristiani alla “spirituale conquista della patria e della vita”. Discorso coraggioso, indubbiamente, anche se pervaso di ibridismo politico-religioso; e comunque pronti a coltivare quel germoglio di nuove speranze dal quale nascerà la pianta del “partito della libertà”. Nascerà più avanti, a fatica, ma con la fortuna e la responsabilità di scrivere una pagina di storia.
5. Discepolo di Murri, Sturzo se ne distaccherà in disaccordo con la scelta di chiudersi, a seguito dello scioglimento nel 1904 dell’Opera dei Congressi, in una sorta di “chiesuola” che avrebbe fatalmente rappresentato per i giovani democratici cristiani lo scivolamento verso posizioni radicali ed elitarie, in aperto contrasto con le direttive del Pontificato di Pio X. Di solito, per capire Sturzo, si indica il discorso di Caltagirone del 1905 come manifesto di quella nuova impostazione che anni dopo legittimerà la formazione del Partito popolare. In pratica, nella sua Caltagirone egli riscrive il “programma della libertà” con la premura di conservarne lo spirito e il contenuto essenziale, ma badando a riportarne le ragioni entro alcune coordinate di compatibilità con la stretta disciplinare imposta dal fervore antimodernista della Chiesa. Insomma, la via sturziana all’autonomia politica e organizzativa del movimento cattolico è fatta di realismo. Era fondamentale scindere l’azione politica dal conflitto sul “nuovo cristianesimo” gettando così le basi del partito aconfessionale, ovvero di un partito capace di trarre dai principi morali e spirituali il lievito per alimentare l’operazione politica in un quadro di laicità, senza compromettere la Chiesa e senza e senza dipendere operativamente.
Il discorso di Milano, tenuto il 17 novembre del 1918 su “I problemi del dopoguerra”, è l’anticipazione dei motivi ispiratori e degli indirizzi programmatici del Partito popolare, fondato ufficialmente due mesi dopo (18 gennaio 1919) con la divulgazione dall’Albergo Santa Chiara dell’Appello ai liberi e forti. Sturzo era stato invitato a parlare sul tema citato appena a due settimane dalla firma dell’armistizio con Vienna. I cattolici avevano dato grande prova di lealtà verso le istituzioni aderendo alla mobilitazione patriottica. Era stato il conte Giuseppe Dalla Torre a spiegare il 5 gennaio del 1915 i motivi per i quali i cattolici, pur tenendo conto della solenne perorazione del nuovo Papa, Benedetto XV, a favore della pace, non si sarebbero sottratti ai doveri legati all’ingresso dell’Italia nel conflitto bellico mondiale. La Vittoria, dunque, non era estranea al sacrificio dei cattolici. “Ancora non si è spenta - esordisce Sturzo - l’eco del plauso, degli inni, degli entusiasmi per la immensa vittoria nostra…”. Ora, partecipi del clima di euforia collettiva, cui seguirà ben presto l’insoddisfazione dei tanti reduci per le mancate risposte alle promesse ricevute al fronte, come pure i timori se non la rabbia di un ceto medio fortemente penalizzato dall’economia di guerra, i cattolici potevano prendere parte con orgoglio e senza remore alla vita della nazione, dando il loro apporto alla riorganizzazione dello Stato.
Sturzo a Milano butta subito le mani avanti: “Nessuna nazione, presto o tardi, sfuggirà alla grande palingenesi”. Il vecchio mondo non c’è più, bisogna mettere mano a un’opera di profonda trasformazione. E precisa: “Farà meraviglia certo, a spiriti superficiali e ai liberali dello stampo classico, sentire che oggi il problema più significativo e l’elemento di contrasto si basa sopra una ragione di libertà”. Adesso sono i cattolici ad issare questa bandiera gloriosa - la bandiera della libertà - consci del declino dell’ordine liberale e della minaccia illiberale insita in una rivoluzione che in Russia, un anno prima, aveva pur trionfato come “prodotto legittimo di ribellione alla casta dominatrice”. Orbene, l’Italia vittoriosa in guerra doveva anche essere, grazie a un programma di giustizia e di progresso, vittoriosa in pace. Questa volontà di rinnovamento passava attraverso riforme concrete e puntuali, per smantellare le strutture burocratiche inutili e i troppi vincoli amministrativi, specie nel campo delle autonomie locali. Il decennio dell’anteguerra aveva esaltato l’interventismo dello Stato nell’economia, sicché il connubio tra il capo della maggioranza e il capo dell’opposizione, Filippo Turati, s’inscriveva nella logica di una progressiva cooptazione della classe operaia a guida socialista, con l’implicita ma evidente sottovalutazione delle prerogative afferenti alla coscienza morale e politica di altri ceti popolari (contadini, commercianti, impiegati). Andava crescendo, secondo Sturzo, un “mostruoso falansterio” anche, e forse soprattutto, per l’assenza di un ruolo attivo dei cattolici. D’altronde, il Patto Gentiloni adottato nelle elezioni del 1913 ne aveva ricercato il consenso solo per garantire ai liberali, in cambio di tutele per gli interessi e le sensibilità di tipo clericale, la conservazione degli equilibri politici consolidati. Dinanzi a una sorta di “tirannia burocratica” che, ad esempio, nella sfera dell’insegnamento imbrigliava le potenzialità o le aspirazioni dei cattolici, si doveva agire per liberare quanto più possibile nuovi spazi di autonomia e partecipazione, rimettendo in circolo le risorse della società civile. Era necessario cioè allargare le maglie del sistema, facendo perno sulla forza dei corpi intermedi. Non deve allora sfuggire, in questa cornice, l’elemento che fa della battaglia per la legge elettorale proporzionale il corollario di un processo di riforma orientato a valorizzare il pluralismo, con una basilare regola di rispetto per tutte le forze in competizione sul terreno democratico.
Da tale analisi discendeva il quesito stringente di Sturzo: “Questo programma di libertà potrà essere attuato dalla borghesia liberale dominante?”. No, era inevitabile che fossero i cattolici a guidare la svolta che il Paese s’attendeva. Per questo l’iniziativa doveva riprendere sulla stessa lunghezza d’onda delle aspirazioni di libertà che nel lontano 1848 erano state, seppur brevemente, alla base di un Risorgimento osannante il primato di Pio IX. Sturzo proponeva dunque di aggiornare il neo-guelfismo con l’impegno a guardare avanti, dando nuovo respiro alla cultura della libertà. A un passo dalla costituzione del partito, egli affermava l’urgenza di un rinnovamento a tutto campo, perché, come diceva alla fine del suo discorso, “oggi si sente il brivido dei rivolgimenti”. Solo in questo modo, rinfrancata dall’empito di libertà presente nell’azione dei cristiani, l’Italia avrebbe occupato il suo posto tra le nazioni “non come museo di bellezze naturali e artistiche, ma come storia vivente e centro fatale del pensiero del mondo”.
6. La libertà e l’autorità rappresentano i due poli che magnetizzano la realtà in cui si esprime la coscienza e la condotta delle persone singole o associate. Quando Mussolini andò al potere, Sturzo e i Popolari furono presto emarginati: il fascismo pretese che il Vaticano sconfessasse il gruppo dirigente del Ppi, puntando il dito contro il fondatore del partito. Cambiò decisamente il clima, pochi resistettero alle pressioni e alle minacce, molti preferirono adattarsi alla collaborazione con il nascente regime autoritario. Sturzo ricevette il consiglio di prendere la strada dell’esilio, magari per il tempo necessario a far calmare le Non era facile tenere testa alla trionfante consacrazione del potere mussoliniano. Avanzava l’idea che tra libertà e autorità l’accento dovesse cadere su quest’ultima, vista la volontà del governo di ripristinare l’ordine a tutti i livelli dopo anni di anarchia. La corrente colerico-fascista raccoglieva consensi superiori alle stesse adesioni formali. I Popolari tuttavia non cedono. Su “Il Popolo” di Giuseppe Donati, un tempo vicino al movimento di Murri ma anche collaboratore in gioventù de “L’Unità” di Gaetano Salvemini, a un certo punto si prende di petto la questione che il titolo della XI Settimana sociale (“L'Autorità Sociale nella dottrina cattolica”), in programma a Torino dal 14 al 19 dicembre del 1924, metteva in primo piano.
Sarà Vincenzo Mangano, un siciliano di radici murriane, a mettere nero su bianco con una lettera aperta (pubblicata il 3 settembre) al prof. Giovanni Battista Biavaschi, già deputato popolare nella legislatura degli anni 1921-1924, al quale era stata affidata una delle relazioni al convegno di Torino. Si temeva quello che poi avvenne, vale a dire la tendenza a coprire la spinta autoritaria del fascismo. “Sorse in me - scriveva Mangano - fin dal primo momento il dubbio che scelto il tema dell’Autorità Sociale, si corresse il pericolo grave di riuscire a conseguenti applicazioni politiche, soprattutto fuori e dopo la Settimana, lasciate all’arbitrio della interpretazione dell’implicito e del non escluso”. Bisogna stare in guardia da un uso strumentale del principio di autorità. Essa - continua Mangano - “non può né deve essere confusa con il Potere, perché è anteriore e superiore ad esso, ne costituisce il controllo ed il limite etico-giuridico ed insieme politico-sociale. L’autorità è un principio coordinatore e di coesione che rivolge le forze e le attività sociali al bene comune”. Il rischio, insomma, è che l’autorità s’identifichi ipso facto con il potere di chi comanda, secondo una tendenza che fa dei governi, dice in conclusione, “veri surrogati dei Cesari, senza le ragioni di equilibrio storico e dinastico che per lo meno quelli potevano vantare al loro arrivo”.
Tanto era seria la questione di come la Settimana di Torino si accingeva a trattare i delicati argomenti all’ordine del giorno, che a distanza di tre giorni, il 6 settembre, Mangano tornava a svolgere le sue considerazioni con un articolo su “Il Popolo”. Il punto era sempre lo stesso, quello della sovrapposizione tra Autorità e potere costituito, con la trasformazione dello Stato in ciò che non è e non deve essere, ovvero la manifestazione della volontà del sovrano. Lo Stato “deve necessariamente avere - precisa ancora Mangano - il triplice compito di coordinare, di promuovere, di integrare le diverse attività che altrimenti resterebbero isolate e discordanti. È per questo che lo Stato non è altro che la Società organizzata politicamente”. È un organo strumentale - chiosa - “destinato ad attuare i compiti ed i fini della Nazione”, sapendo che “è abusiva, infondata ed illusoria, l’equazione Stato e Nazione, come altresì l’altra Stato-Autorità”.
Dunque la posizione intransigente dei Popolari, resa esplicita in questo dibattito sugli orientamenti della Settimana sociale, contempla il rifiuto della tentazione autoritaria. Di fronte al neocesarismo impersonato da Mussolini, essi oppongono la concezione di uno Stato fondato sul rispetto del pluralismo e delle libertà. Anche don Giulio De Rossi, il parroco di San Saba nel quartiere omonimo di Roma, stretto collaboratore di Sturzo in qualità di capo ufficio stampa del Partito popolare, ribadirà questa visione in un articolo che già nel titolo (“I pericoli del neocesarismo e l’obbedienza al governo”) faceva toccare con mano le distanze dal fascismo. Nel testo pubblicato su “Il Popolo” il 12 settembre, si poteva rintracciare una conclusione fulminante. “Niente neocesarismo dunque - scrive don Giulio -, ed anzi lotta vigile perché si arresti la sua maturazione” …”Solo così, a me pare, noi possiamo assolvere il nostro compito che non è quello di imporre con la forza una disciplina esteriore alla Nazione, ma che è invece quello … di far rientrare tutti nei ranghi della giustizia e della moralità, affinché dalla Nazione intera balzi intimamente la propria disciplina interiore”.
Era prossima la svolta decisamente autoritaria del fascismo. Con le leggi fascistissime, emanate nel biennio 1925-1926, l’accentramento del potere nelle mani dell’esecutivo, nonché la soppressione dei partiti e della libertà di stampa, si entrava nel ciclo buio della dittatura. I Popolari non riuscirono ad arrestare la maturazione del neocesarismo. Alcuni di loro pagarono un prezzo salato, chi con l’esilio (Sturzo, Ferrari, Donati) e chi con il carcere (De Gasperi), altri ancora con l’emarginazione sociale e il silenzio imposto dal controllo di polizia. Tennero accesa la fiammella degli ideali per l’onore di un partito che proprio Don Giulio De Rossi continuò a chiamare, fino alla morte che lo colpì nel pieno delle forze, il partito delle libertà o meglio, come lui amava precisare, delle “libertà organiche” e delle “libertà cristiane”.
7. Negli anni ‘30 gli intellettuali cattolici presero ad interrogarsi sulla crisi della democrazia e la crescita dei La guerra civile spagnola (1936-1939) determinò la presa di posizione, a livello europeo, di molti di loro contro l’appoggio dei cattolici allo schieramento franchista. La condanna del comunismo, ribadita dall’enciclica Quadragesimo Anno, non poteva autorizzare il rifugio nello schema illiberale del fascismo e del nazismo. In Italia le leggi razziali del 1938 contribuirono a inceppare il meccanismo del consenso che i Patti Lateranensi, chiudendo il contenzioso tra Stato e Chiesa, avevano impostato. Con l’esplosione della seconda guerra mondiale divenne urgente riprendere i fili della vicenda politica sturziana, scegliendo tuttavia di rompere con la continuità formale in nome di un rinnovamento, anche nella stessa denominazione di partito, che avrebbe contraddistinto appieno l’iniziativa di De Gasperi all’indomani del 25 aprile del 1945. Su un punto il leader trentino fu irremovibile, nel considerare cioè l’antifascismo una “pregiudiziale ricostruttiva”, come aveva scritto a poche settimane dalla caduta del regime a Sergio Paronetto (il manager dell’Iri, scomparso molto giovane, che spinse De Gasperi ad accantonare i ferri vecchi del corporativismo per investire sul modello dell’economia mista).
In quella lettera si può leggere anche la preoccupazione per la persistente “mentalità antilibertaria, […] l’ambizione giacobina d’improvvisare le riforme, la suggestione del nuovo e dell’ardito a qualunque costo”. La Democrazia cristiana doveva incarnare, con la forza dei suoi ideali, l’esigenza di riordinare lo Stato su basi di autentica libertà e giustizia. Fu compito di Guido Gonella, con un intervento magistrale al congresso che si tenne a poche settimane dal referendum istituzionale e l’elezione dell’Assemblea Costituente, esporre compiutamente i lineamenti e i contenuti della proposta politica democristiana. Fu chiamato il “Discorso delle 27 libertà” e dette modo a De Gasperi di parlarne come di un “monumento” per la ricchezza delle argomentazioni e la chiarezza dell’architettura..
Benché l’azione della Dc rifuggisse dall’estremismo post resistenziale, considerando errata la pretesa di edificare il nuovo Stato a forza di pregiudiziali e colpi di mano, come pure di prolungare oltre misura le funzioni direttive del CLN a danno fatalmente della iniziativa e responsabilità dei partiti; ecco, benché prudente e ragionata quest’azione voleva articolarsi sul tracciato di una politica di rigenerazione democratica, facendo delle “27 libertà” il contrassegno di un vero cambiamento del Paese. La Dc non era il partito della restaurazione borghese nella quale oltretutto s’allungava, a detta della propaganda laicista, l’ombra della sudditanza alle mene del clericalismo. Sicché la difesa, anzi l’esaltazione delle libertà attestava lo slancio di un progetto che muoveva dalla critica del liberalismo classico, solo in parte collimante con la cultura del popolarismo. D’altronde Gonella aveva impegnato la sua penna nella descrizione di un partito che in virtù dell’ispirazione cristiana ripudiava la filosofia del borghesismo, immanente e scettica, pervasa di materialismo: una filosofia di per sé incapace di guardare oltre la dimensione dell’homo oeconomicus. Un suo editoriale su “Il Popolo” del 9 settembre del 1944 s’apriva con questa frase icastica: “La democrazia cristiana, partito di centro e di masse, è di sua natura un partito antiborghese; in quanto democrazia cristiana si oppone alla gretta e corrotta morale borghese”. E così proseguiva: “Il nostro programma di elevazione del proletariato ci colloca al polo opposto di questa borghesia”.
L’ispirazione cristiana obbliga a sintonizzare il programma della libertà sulla lunghezza d’onda della giustizia sociale. Non è un manifesto di glorificazione del profitto, motore immobile del liberismo economico, bensì la Magna Charta della emancipazione degli umili. Su questo si gioca la credibilità della nascente dirigenza scudocrociata. L’opzione centrista equivale alla ricerca, in primo luogo, di uno spazio ideale tra dirigismo e sfrenatezza di mercato. Con il nuovo ordinamento dello Stato si vuole altresì impedire la formazione di grandi monopoli economici e finanziari, destinati ad esercitare, se lasciati al loro impeto, un largo controllo sulla dinamica degli interessi e dei bisogni sociali. Conta allora, per De Gasperi e i suoi amici di partito, arrivare alla Costituente con una organica piattaforma programmatica e soprattutto con la consapevolezza degli obiettivi da raggiungere nel confronto con le altre forze politiche, sapendo che lo spirito di mediazione dovrà guidare i lavori dell’Assemblea.
Quando sale alla tribuna Guido Gonella per illustrare la sua relazione (“Il programma della Democrazia Cristiana per la nuova Costituzione”), la mattina del 25 aprile, il congresso aveva già votato, il giorno prima, l’ordine del giorno a favore dell’indirizzo repubblicano (750.00 voti a fronte dei 245.000 per l’indirizzo monarchico). Terrà per due ore e mezza (o forse tre) un discorso “pronunciato con accento di salda convinzione”, seguito con la massima attenzione dalla platea dei delegati, come annotava diligentemente il cronista del quotidiano di partito (in seconda pagina, nell’edizione del 27 aprile, “Il Popolo” presentava la sintesi della relazione con il seguente titolo ad effetto: “La Costituzione della libertà attuata dal cristianesimo”). Sommariamente, i quattro punti cardinali della relazione si potevano rintracciare nella riforma agraria e nella legislazione antimonopolistica, per gli aspetti economici, e nel sistema parlamentare bicamerale e nella istituzione di una Corte Suprema incaricata di giudicare la costituzionalità delle leggi, per gli aspetti istituzionali. Naturalmente c’è dell’altro, molto altro ancora. Fluviale ed appassionata, l’oratoria di Gonella rivelava il desiderio della Dc di presentarsi sulla scena pubblica come un partito dalle salde radici culturali e con una visione politica all’avanguardia. L’appello a un cristianesimo amico della democrazia, laicamente riflesso in una formula di ingaggio politico, si ramificava nel ragionamento sulle tante facce, diverse ma complementari, della libertà.
8. È stato Giovanni Spadolini a coniare l’espressione di “governo a popolo” come sintesi della novità di approccio di Gonella alla questione democratica. I tre momenti di Lincoln - “governo del popolo, dal popolo, per il popolo” – si trasfondevano nella evocazione di questa consustanzialità tra i soggetti in campo: il popolo e il governo. Era il sogno di una democrazia pulsante di vita e di speranza, alla cui promozione si dovevano disporre i democratici cristiani, i quali, nelle parole di Gonella, non erano affatto dei “fantasmi tra i ruderi”. Essi appartenevano alla schiera dei progressisti, seppur con la loro originale vocazione. E qui immediatamente, partendo dalla riflessione su Dio e la libertà, il susseguirsi di affermazioni e precisazioni del tipo: “le libertà dell’uomo sono anteriori allo Stato”…“non vogliamo una libertà che sia un vuoto”…”la libertà, quindi, per noi non è un fosso, ma un ponte”. In fondo, ricordava Gonella, anche la guerra del 1914-1918 era stata una guerra per la libertà dei popoli. A questi ancoraggi storici e ideali si legava pertanto il messaggio dei cattolici, adesso che sulle loro spalle, per il tramite della Dc, gravava il peso maggiore delle responsabilità di governo. Da pochi mesi, infatti, De Gasperi aveva assunto la carica di Presidente del Consiglio e ciò consacrava la fine di ogni esclusione o marginalità dei cattolici. In effetti, passando per il secondo Risorgimento - anche molti sacerdoti avevano versato il sangue nella guerra di liberazione dai nazi-fascisti - si portava a compimento ciò che nel primo Risorgimento era stato avvilito a causa del conflitto con la Chiesa.
Nelle tesi di Gonella tornava a vibrare il concetto di homo politicus che dalla scolastica medioevale arrivava alla filosofia moderna attraverso il filtro di Rosmini. Era il pensiero ispirato al cristianesimo che incarnava la risposta alle illusioni del secolo dei Lumi. Perché Rousseau sbagliava? Contrariamente al mito del buon selvaggio, l’uomo è più libero nella società che non prima della società. Ebbene, rifiutando questo assioma l’illuminismo del ginevrino cedeva alla rappresentazione di un mondo in cui la bontà originaria dell’uomo pativa gli effetti del contratto sociale. Convenzionalmente la libertà del singolo si consegnava alla società - alle sue norme e alla sua disciplina - per ritornare in sé, entro i limiti di una sovranità che la legittimava, in forza soprattutto di una permanente funzione educativa dello Stato e della politica. Ma così l’orizzonte si fa buio perché dietro l’educazione, chissà come organizzata, si affaccia sempre il rischio di un dirigismo delle coscienze che prelude alla manipolazione della libertà personale. Semmai, al posto della educazione si staglia la responsabilità della persona in ordine alla sua stessa formazione, animatrice dello Stato democratico, perché “la libertà - come aveva scritto Guerrazzi e adesso ricordava Gonella - è un albero che non dà frutti se non è coltivato con le proprie mani”. Questo messaggio di allerta si rendeva necessario in un tempo di incertezze, quando ancora i partiti si apprestavano a consolidare la riconquista della libertà. Più che l’etica dello Stato, cui doveva guardare la coscienza del credente all’alba della nuova Italia democratica, poteva riemergere la figura dello Stato etico. La dittatura non era il proprium del fascismo, ma una “malattia cronica in varie età della vita politica italiana”. Guai a deflettere perciò da un compito di rinnovamento mercé la consapevolezza del ruolo assegnato dagli eventi a un partito democratico di matrice cristiana. La sua esistenza escludeva che la libertà fosse consegnata al monopolio dei partiti liberali o la giustizia alla rivendicazione dei partiti di sinistra.
Libertà e giustizia sociale costituivano un binomio inscindibile. Ognuno per la propria parte, ma con finalità dettate dall’impegno per uno Stato nuovo e una società nuova, concorreva a indirizzare il processo democratico. Non si doveva presupporre che l’adesione alla democrazia sciogliesse per incanto i nodi della dialettica politica e oscurasse le ragioni inerenti la diversità di programmi e strategie. Lapidaria, a questo riguardo, la frase di Gonella: “La democrazia non è, di per sé, la virtù: è la possibilità della virtù”. La possibilità, ovviamente, di stare dalla parte giusta o dalla parte sbagliata: per questo la Dc aveva il dovere di presentarsi con la forza delle proprie idee, indicando come meta l’uscita dal sistema del privilegio e dell’egoismo sociale, per costruire nella libertà uno Stato in grado di garantire un’azione politica indirizzata alla “redenzione delle masse”. Il programma dei democratici cristiani, a cui il discorso dedicava massima attenzione illustrandone il contenuto per ogni singolo capitolo, si mostrava in tutto il suo carattere di autonomia e originalità. Era l’espressione della Terza Via dei cattolici democratici. “Fra il liberalismo e il socialismo - proclamava infine Gonella - deve affermarsi la nostra democrazia che è progressista senza essere “progressiva”, cioè senza condurre alla paralisi progressiva del sistema della libertà”.
9. L’apporto di Gonella alla elaborazione della Carta costituzionale non ebbe sviluppi diretti, riconducibili alla sua persona, perché nel luglio del 1946 fu nominato Ministro della Pubblica Istruzione. Tuttavia, l’analisi del discorso al congresso, in linea per altro con quello tenuto alcuni mesi prima alla XIX Settimana sociale dei cattolici (Firenze, 22-28 ottobre 1945) sul tema “Vitalità e decadenza delle costituzioni”, permette di stabilire in sede storica che l’intellettuale e politico veronese esercitò una indubbia influenza sulla linea dei costituenti democristiani, in sintonia con il lavoro dei “professorini” (Dossetti, Lazzati, Fanfani, La Pira e, per estensione, Moro) e di altri giuristi (Mortati, Ambrosini, Tosatti). Giova osservare come agli esordi della Repubblica i cattolici, radunati attorno alla leadership di De Gasperi, seppero mettere ordine nel lavoro di preparazione alla nuova stagione democratica dell’Italia. Anche a scorrere le pagine del “Codice di Camaldoli”, avviato nel 1943 ma pubblicato nel 1945, si coglie la vasta condivisione di temi e suggestioni nell’ambito di un medesimo orizzonte valoriale. Nei vari documenti, ognuno con la propria impostazione, è riconoscibile la premessa politica basilare che attiene al riconoscimento del substrato filosofico dell’uomo come essere socievole, disposto ad esercitare il bene e capace di riconoscere il male: un uomo con risorse sufficienti a guadagnare, nei limiti della sua condizione creaturale e per effetto della grazia salvifica, la possibilità di riscatto dalla colpa e dall’errore. A questa antropologia positiva, lontana dal pessimismo sulla natura irrimediabilmente corrotta dell’uomo, corrispondeva o doveva corrispondere una politica impregnata di realismo e creatività. Dal che veniva la spinta a un proposito di rinnovamento, in un’Italia tutta da ricostruire, evocativo di un umanesimo che oltrepassava ogni nostalgia per la compatta cristianità medievale. Era un proposito che l’azione di partito rendeva quanto meno visibile, se non credibile. In definitiva, le idee non si perdevano in un circuito di testimonianze sparse, disarticolate rispetto alla politica; né la politica, per essere efficace e convincente, poteva fare a meno di quelle testimonianze. Nella connessione operava un di più che altrimenti sarebbe andato perso, con danno generale. Neanche il Codice di Camaldoli, ciclicamente ricordato come alto contributo dei cattolici alla vita democratica, avrebbe avuto la stessa risonanza se non fosse diventato il libro bianco della classe dirigente democristiana.
Cosa emerge, dunque, dalla ricognizione che ha come epicentro la libertà nell’accezione democratica e cristiana? Indubbiamente, grazie al confronto con la libertà dei moderni, l’iniziativa dei cattolici ha messo radici profonde e poi è cresciuta, passo dopo passo, diventando nel tempo sempre più ambiziosa, tanto da prendere in consegna il peso e il valore di quell’aliquod regitivum che nel linguaggio corrente equivale a funzione egemonica nella struttura democratica della società e dello Stato; e tuttavia è cresciuta non perché chiusa in difesa di un qualche ordine costituito, magari per gestirne l’ineliminabile tensione solidaristica, ma in virtù del confronto con le istanze della modernità, tutte annodate attorno al problema della libertà. Lo ha fatto senza nascondersi le insidie o le ambiguità, cogliendo anzi la natura della sfida che il problema recava in sé, a seconda delle epoche e delle forze in campo, con l’occhio sempre rivolto ai possibili interlocutori. Nel secolo Ventesimo il cattolicesimo politico si è imposto a passi lenti e faticosi, fino a caratterizzare fortemente la vicenda repubblicana dal 1946 al 1994, per andare poi incontro, al culmine di un potere ingessato nella “eternità democristiana”, a un crollo strutturale finanche sorprendente.
Accadeva che l’impero sovietico implodesse di fronte a un Occidente attonito e sorpreso. Allora un’Italia tutta nuova, affrancata dagli obblighi della lotta al comunismo internazionale, seppelliva il vecchio “partito delle libertà” come calco storico del “partito d’ispirazione cristiana”. La sua dimensione politica era risucchiata in un grande buco nero. Dal vuoto è scaturito altro vuoto, uno smarrimento più intimo e diffuso, persino un graduale congedo dalla politica. Non bisogna sottovalutare gli effetti collegati allo scardinamento della “repubblica dei partiti”: l’ondata moralizzatrice, liberando dalla lampada il genio dall’ antipolitica, ha introdotto i l fascino della semplificazione. Nella mentalità comune tutto è apparso più facile e più diretto, senza inutili ingombri. Alla stessa stregua, s’è fatta più esplicita la proiezione sociale della Gerarchia e più debole l’autonomia politica dei laici. Alla lunga sono risorti i mali, gli errori, le immaturità che avevano affollato la storia antecedente alla nascita del partito aconfessionale pensato e voluto da Luigi Sturzo. Invece di avanzare, battendo sentieri inesplorati con l’accresciuta esperienza del passato, si è tornati indietro. E così l’illusione di un progetto culturale e civile costitutivamente separato da un progetto politico ha disorientato e infragilito l’opinione dei cattolici. S’è archiviato in fretta e furia un intero patrimonio, lasciando libera la strada, nella concordia discors del nuovo bipolarismo, a un revisionismo politico- istituzionale di dubbia qualità. Ne ha risentito, passaggio dopo passaggio, lo spirito democratico del Paese. Invece di innalzare l’asticella del rigore per rispondere alla domanda di moralità, si è tollerato confusamente un diritto all’improvvisazione.
La questione della libertà ha preso il giro largo della fraseologia di circostanza, ora per decantare un liberismo nemico di ogni freno alle virtù del mercato, ora per coprire goffamente le aspettative delle diverse corporazioni, ora per accendere la polemica attorno al tradimento delle élite liberali e progressiste; un giro largo e al tempo stesso vizioso per le contraddizioni presenti al suo interno, in cui gli attori in campo sono obbligati, pena lo sfarinamento del sistema, a impugnare l’arma della personalizzazione come forma dirimente del processo democratico. Una libertà spogliata dei valori essenziali, libera essa stessa di fare a meno della partecipazione e della solidarietà, e quindi aliena dal bisogno di muoversi a giustizia nell’ottica del bene collettivo, sfuma nella configurazione di un potere più compatto. Conta anzitutto il leader. In maniera silenziosa il rapporto tra autorità e libertà perde il suo equilibrio a vantaggio di un modello di democrazia che la parola cesarismo, malgrado il suono antico, riesce comunque a definire nel suo contenuto più attuale. Resta tuttavia la critica: essendo una parola vetusta per il linguaggio della cyber-democrazia, quanto può valere ai giorni d’oggi? Ha senso usarla per sintetizzare la crisi della democrazia? L’interrogativo serve a confondere le acque. Infatti, non c’è termine migliore di cesarismo per descrivere la tendenza a collocare la libertà sull’asse prevalente dell’autorità, inquadrando il pluralismo, sebbene formalmente rispettato, in una logica di accentramento e verticalizzazione del momento decisionale.
La libertà, per altro verso, subisce la torsione iper-libertaria prodotta da “una mente senza incarnazione” (Gaudete et exultate). L’uomo è ciò che la cultura, orma del tempo, auspica o determina nel passaggio oltre il confine del dato di natura. Al potere scientifico si concede di liberare la natura umana, emancipando in assoluto la morale, ma gli si fa obbligo in sostanza di rispettare il palinsesto dell’ambiente (l’unica natura che merita di essere riconosciuta). Anche la vita e la morte accedono a un destino di trasvalutazione, quello che si specchia appunto nel cosiddetto post-umano, dove conta la volontà e il desiderio dell’io padrone di se stesso. E però, quando ognuno sperimenta l’ossimoro di una società organica e atomizzata, il cui affanno sta nella ricerca di una forma “altra” di coesione, quella che il radicalismo etico non riesce a garantire nel concreto, scatta un meccanismo d’introversione che trova il suo riverbero nella critica alla democrazia. Ad essa si attribuisce la colpa di non essere adeguata, come se ciò dipendesse da un’alterazione del congegno adibito a regolarne il funzionamento, piuttosto che da una sottrazione di responsabilità risalente perlopiù alla condotta personale e collettiva. All’eccitazione dell’io desiderante fa da contrappeso il malessere dell’io sociale, anche quando non siano riscontrabili, all’origine di questo malessere, precise cause materiali (povertà, discriminazione, isolamento sociale, ecc…).
10. Allorché la fibra morale di una nazione o di un popolo patisce la perdita del senso collettivo dei diritti e dei doveri, la libertà non va più ad innervare il progresso e la giustizia. In ultimo diventa l’armatura dell’individuo anteriore alla comunità. Se non fosse per l’oblio in cui è caduto il messaggio di Mazzini, il più testardo nel sostenere la tensione spirituale del Risorgimento, quella “dei diritti e dei doveri” sarebbe la giusta endiadi da riproporre oggi, con serena convinzione, per dare una cornice più ampia alla formulazione di un umanesimo democratico e sociale, per il quale combattere la buona battaglia.
Non è un’impresa che susciti un’adesione vigorosa, perché le correnti democratiche, scorporate dal retaggio di onori e vanto per il contributo assicurato allo sviluppo del Paese, sono tutte debilitate. Una patina di disincanto ne compromette la vitalità, un contro esercizio di smemoratezza ne paventa l’insignificanza nel frastuono della comunicazione di breve durata. A prima vista, l’ombra del pessimismo s’allunga sul presente e fa del travaglio interno alla vita democratica un problema avulso dalla storia, senza traccia di memoria, fuori dal tempo. Il continuo rimbalzo della novità elettrizza la percezione subitanea. Certo, è oggi che incombe la tirannia dell’algoritmo o la minaccia dell’intelligenza artificiale, ma l’attrazione e l’angoscia per la tecnica sono il combinato disposto di una più antica e più profonda inquietudine della coscienza umana. “La vera causa della crisi è nell’uomo”, scriveva già un secolo addietro Giuseppe Capograssi (Opere, vol. 1) osservando il lato oscuro della dialettica tra autorità e libertà. E ne dava una spiegazione che rifuggiva da una lettura moralistica della storia, andando con il pensiero al cuore della questione sorta con l’età moderna: a suo giudizio, infatti, occorreva riflettere sulla portata di un “infinito desiderio di libertà: dopo la rivoluzione francese, esso è entrato come elemento principalissimo nella storia e ha gettato in crisi la società contemporanea”.
Ma siamo ancora dentro questa crisi? Probabilmente sì, guardando alla lunga durata dei fenomeni e alla loro connessione filosofica; ma proprio nel riconoscimento di questa crisi “lunga” c’è anche la “lunga” traccia di una risposta in continua evoluzione. Sempre Capograssi ne traeva la speranza che fosse possibile una nuova libertà in grado di proporsi al di là e al di fuori dell’individuo immediato e primitivo, chiuso nella sua autosufficienza, in sostanza “affrancato da qualunque autorità”. Bisognava scavare nel fondo della realtà, laddove residua la potenza della verità, per rinvenire un annuncio di speranza contro il pessimismo. Tornava in questo approccio l’elemento centrale della storia che Vico aveva scorto nella Provvidenza. Il più stabile dei fenomeni può anche rovesciarsi nel suo contrario, subendo dall’interno il passaggio ad un’alternativa fino a quel momento inattingibile. Ecco lo scatto che immaginava Capograssi: “(…) il pessimismo moderno è il miglior motivo di speranza che l’epoca moderna presenta (…) e difatti dal cuore profondo dell’uomo, confusa (e) ancora crepuscolare, risorge ancora la grande idea della fraternità (…) L’ultima parola del pessimismo moderno non è «dispera l’ultima volta» ma è questa: creare di fronte alla indifferenza dell’universo una vita concreta nella quale l’uomo si senta fratello all’altro uomo nella stessa miseria, nello stesso bisogno e soprattutto nella stessa volontà di liberazione”.
Ebbene, dire che l’idea di fraternità risorge significa ammettere che questa suggestione, per la quale riluce l’inatteso cambio di prospettiva, non sottostà al gioco di causa-effetto del determinismo. “Quando gli uomini sono andati tanto lontano e si sono sprofondati con così ardente volere nel fatto, solo il fatto può riportarli alla luce dell’intelligenza”. Non un’astrazione o un idillio, ma il fatto: un bagno salutare nel realismo. Qualcosa sopraggiunge, dunque, nel mezzo di un presunto destino di contrazione e irrigidimento dell’umano; qualcosa di notevole che restituisce, nel flusso della vita e dello spirito, l’uomo alla libertà e la libertà all’uomo, procurando un sentimento di apertura alla dimensione della fraternità.
Ora, mentre una tale sollecitazione innalza il livello del confronto sul domani della società, evidenziando il persistente bisogno di solidarietà tra le persone, il dibattito più immediato sulle criticità della democrazia ruota in massima parte attorno a rimedi tecnici che spostano l’attenzione sulla funzionalità ed efficacia delle procedure di governo. In una scala di valori, la decisione è più in alto della partecipazione, il leader viene prima della sua compagine, il cerchio magico - ne esiste sempre uno per ogni partito - si costituisce e si comporta come se fosse superflua o persino sconveniente l’applicazione nei suoi riguardi di una procedura di legittimazione trasparente. L’esperienza di partito risulta compromessa dal tarlo della immoderata personalizzazione della lotta politica sicché il “Capo”, forte di una diretta investitura, è indotto a sovraordinare la sua funzione di leadership al rispetto della delega ricevuta. Appare evidente come a lungo andare il modello poliarchico, confacente a raffigurare senza fronzoli lo scheletro della democrazia moderna, scivoli nel travisamento delle regole o perlomeno nella loro deformazione pratica. Includere non è più l’accertata missione delle classi dirigenti, e cioè il servizio che possono rendere, nell’alternanza delle responsabilità al vertice dello Stato, allo sviluppo di una società aperta, capace di contenere l’aggressione degli interessi dominanti e impegnata a mantenere desta l’esigenza di un’equa organizzazione delle pubbliche risorse. La malattia dell’Occidente si rivela nella perdita di un “baricentro etico”, in sostanza un luogo di valori condivisi e di opzioni convergenti, essendo egemone la convinzione che dalla dialettica tra opposti schieramenti, obbligati a irrigidire le loro posture ideologiche, emerga un guadagno di chiarezza e di forza in funzione della governabilità del sistema.
Il gioco consiste allora nell’escogitare una panoplia di norme selettive che nel complesso, specialmente guardando all’Italia, sono così esplicitate: riduzione della rappresentanza elettiva, premio di maggioranza e soglia di sbarramento, numeri più alti per la composizione dei gruppi parlamentari, centralità dell’Esecutivo nel campo della legislazione (decreti legge), anche con strumenti idonei a regolarne lo svolgimento alle Camere, fino alla prospettata investitura popolare dell’autorità apicale di governo. Se lo scopo dichiarato è la maggiore efficienza, il prezzo pagato è la mortificazione delle minoranze e lo svilimento del pluralismo.
L’involuzione è tangibile anche se resiste, malgrado tutto, l’intelaiatura classica della concezione democratica. Sicuramente, dal punto di vista del “cristianesimo democratico” l’insieme di tante forzature è la negazione della politica che Paolo VI amava definire come la forma più alta della carità. In genere le distorsioni producono sgradite conseguenze. Allo scadimento della politica consegue la prepotenza e l’ingiustizia, malgrado le illusioni che promanano dal messaggio di emancipazione - ovvero di esenzione - dalla fatica del confronto democratico. Ogni compromesso, anche quando s’impone per la gravità dei problemi, è visto con fastidio. Invece di investire sulla razionalità del dialogo, fonte primaria di alimentazione del consenso, si sopporta la tirannia del dissidio esasperato, quali ne siano le motivazioni. Il terreno si presenta sempre più arido perché alla lunga, sugli esempi del passato, può anche rivelarsi inospitale per le battaglie valoriali. Qui non risorge l’idea di fraternità, che reclama la virtù operosa della politica come progetto e creazione, e quindi come sintesi diuturna di bisogni ed interessi, bensì la malìa di un qualche snellimento del comando. È la proclamazione del potere solitario, l’effetto ultimo, cioè, di un’eclissi di valori che regala ancora più potere a vecchie e nuove oligarchie. Niente a che vedere, in definitiva, con l’azione diretta a costruire un’alleanza tra tutti coloro che - credenti e non credenti - sul binomio di democrazia e libertà, congiunto a quello di partecipazione e responsabilità, intendano coltivare con tenacia la prospettiva di una società spiritualmente e materialmente più avanzata, avendo cura di “liberare la libertà” dall’ossidazione provocata dalla fiamma dell’io totale.
È l’io prigioniero di se stesso e del suo anelito di indipendenza. Con il che, all’orizzonte, l’eterogenesi dei fini ricompare. Questa dura corazza dell’egolatria soffoca la speranza e senza la speranza la libertà si snatura o non sussiste. Il futuro esige come non mai uno sforzo di creatività. Ci sono tessere di un grande mosaico, nel quadro complicato della discontinuità tecnologica e ambientale del nostro tempo, che il pensiero e la politica dei cristiani hanno il dovere di ricomporre. Non è giusto farsi da parte.
Lucio D’Ubaldo
per gentile concessione dell'Autore